Quando le parole fanno male anche senza essere insulti
di Anna M. Thornton
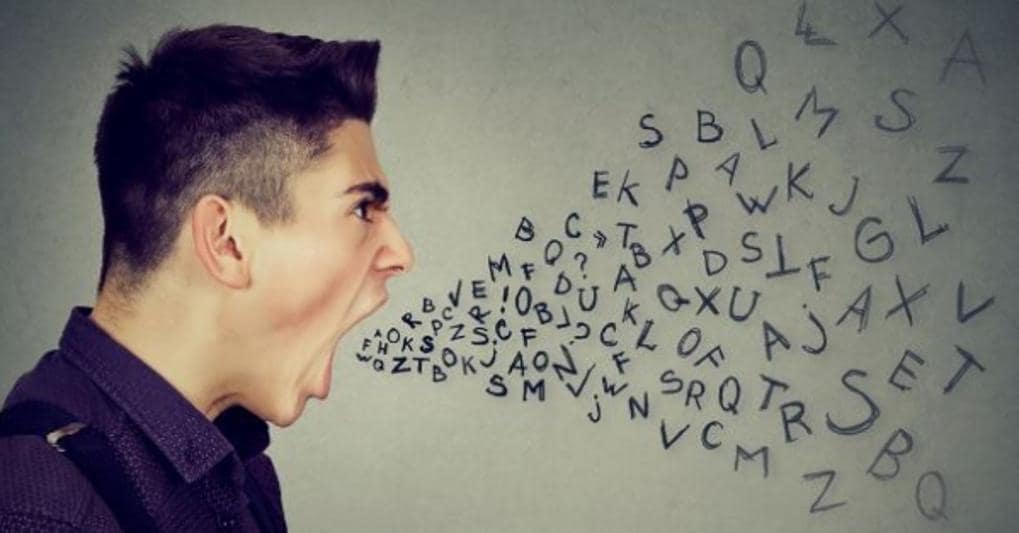
3' di lettura
Tra le forme di violenza che le donne subiscono, c’è anche quella linguistica. Come si fa a far male alle donne con le parole? «Mi fai male con le parole» è la lucida formulazione adottata in un importante convegno tenuto a Ca’ Foscari qualche anno fa in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il modo più evidente di far male con le parole è quello degli insulti sessisti, ma ce ne sono altri, più sottili.
Uno è stato recentemente molto discusso (per esempio, in un articolo di Giovanni De Mauro su Internazionale del 12 novembre): scrivere che «una donna» è stata eletta vicepresidente degli Usa, o rettrice dell’Università La Sapienza, senza farne subito il nome, oscura l’identità della persona che ha ottenuto questi riconoscimenti.
Un altro modo è quello di nominare le donne con termini maschili. Paola Di Nicola, a lungo costretta a firmare «il giudice» le proprie sentenze, nel libro “La giudice” scrive: «Non nascondo un moto di indignazione e rabbia nel dovere interpretare, nella mia funzione di giudice, le parole maschili come comprensive anche del femminile».
Sulla scelta dei nomi da usare per riferirsi a donne che ricoprono cariche c’è molta incertezza. Le stesse donne sono divise: ci sono ministre che hanno voluto essere chiamate ministro (come Stefania Giannini) e altre che hanno richiesto esplicitamente di essere chiamate ministra (come Valeria Fedeli). Laura Boldrini voleva essere chiamata la presidente della Camera, e Maria Elisabetta Alberti Casellati vuole essere chiamata il presidente del Senato. E gli esempi potrebbero continuare.
Perché alcune donne preferiscono essere designate con nomi maschili? Una risposta si legge già nel testo pionieristico di Alma Sabatini, “Il sessismo nella lingua italiana”, che nel 1987 scriveva: «Il desiderio, non sempre conscio, di dar risalto al diverso livello della carica è forse spesso il motivo che induce molte donne nei gradi più alti a preferire il titolo maschile». Il maschile è dunque percepito come dotato di maggior prestigio.
Un’altra motivazione che spesso emerge nelle dichiarazioni di donne che preferiscono autodesignarsi al maschile è che certi nomi al femminile hanno connotazione scherzosa o, peggio, sono usati a fini di scherno, anche quando sono grammaticalmente ineccepibili (perché non dire la ministra se diciamo la maestra?). L’intento di schernire e ridicolizzare le donne accompagna spesso i primi usi di termini femminili per denominarle; Alfredo Panzini nel 1905, nel suo Dizionario moderno, alla voce dottora scriveva: «Ora le donne addottorate in qualche disciplina, così fiere come esse oggi sono della loro dignità, come chiamarle? A dottora non ci si ausa e dottoressa sa di saccente, e pare contenere in sé alcuna parte di scherno o almeno di estraneo all’ideale femminista: onde è che le donne che hanno diploma di laurea, scrivono spesso sul biglietto dottore».
Ai primi del ’900, per evitare lo scherno una donna laureata si diceva dottore. Oggi, oltre un secolo dopo, è normale dirsi dottoressa. Questo ci mostra che con l’uso, nel tempo, si perde la connotazione scherzosa o spregiativa di nomi di professioni e cariche al femminile.
Quindi va accolto con grande favore il lavoro che Il Sole 24 Ore sta avviando al suo interno per adeguare il modo di riferirsi alle donne usato nei suoi articoli. Incontrare sulle pagine del principale quotidiano economico-finanziario italiano nomi femminili (ministra, sindaca, la presidente, ecc.) per riferirsi a donne sarà un contributo importante contro le due violenze dell’oscuramento e dello scherno.