Scienziati in tv solo se con l’autorizzazione: molto rumore per nulla?
di Carlo Melzi d'Eril e Giulio Enea Vigevani
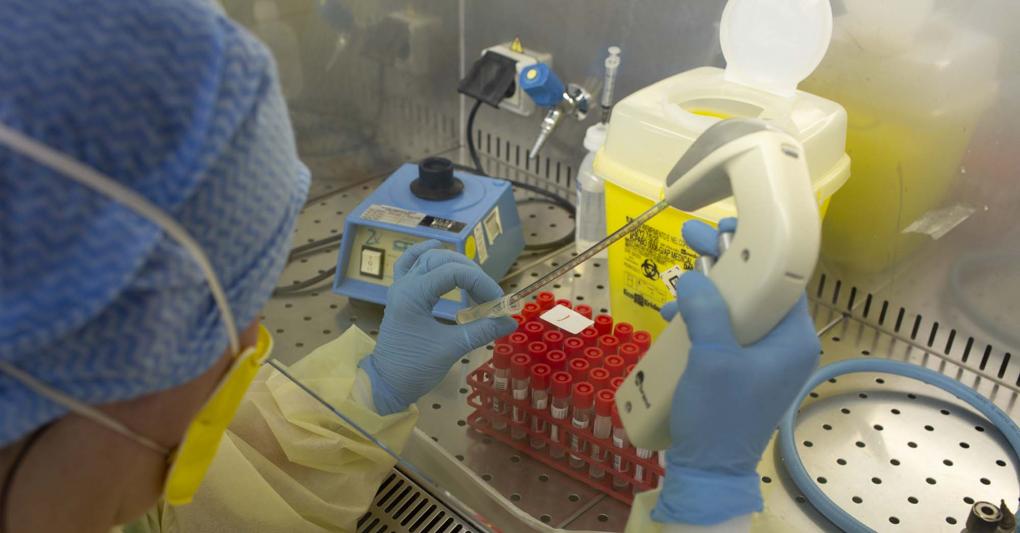
(IMAGOECONOMICA)
La discussione sull’ordine del giorno Trizzino: è bene che il legislatore sanzioni gli abusi della liberta di espressione, ma si astenga dal prevenirli
4' di lettura
Nella massa dei molti atti di indirizzo presentati da parlamentari sull'emergenza Covid, discussi e approvati nel totale disinteresse dell'opinione pubblica, uno ha infranto il muro dell'indifferenza, sino a occupare le migliori penne del giornalismo italiano, quali quella di Michele Serra.
Informazione e pandemia
Mercoledì scorso il governo ha accolto, forse improvvidamente, un ordine del giorno del deputato Trizzino, medico eletto nelle liste dei 5 Stelle e come molti ora nel Gruppo misto, che mirava a regolare l'informazione sulla pandemia.
Nello specifico, il governo si è impegnato a valutare l’opportunità di trovare soluzioni efficaci per la programmazione e il coordinamento delle informazioni, di prevenire e contenere la divulgazione di fake news nonché, soprattutto, di imporre a medici e scienziati l'autorizzazione della struttura propria sanitaria di appartenenza prima di poter esprimere il proprio pensiero su qualunque mezzo di comunicazione.
Scienziati sui media: si valuta autorizzazione
È evidente che tale ordine del giorno non produce alcun effetto giuridico. Questo anche perché il governo si è solo impegnato “a valutare” e non certo a intervenire nel senso voluto dal presentatore.Tuttavia, la sola idea di riservare la presenza sui media agli scienziati “autorizzati” ha prodotto critiche quasi unanimi: alcuni, forse in modo eccessivo, hanno richiamato le pratiche del fascismo, altri, più sottilmente, si sono chiesti come si potrebbe mai dare la patente agli autorevoli e negarla ai cialtroni.
E, in effetti, la ricetta dell'onorevole medico non appare solo poco compatibile con i principi costituzionali ma, il che è peggio, dannosa. Proprio nelle emergenze, solo un'informazione libera e polifonica può garantire ai cittadini che non venga loro nascosto qualcosa e che la situazione, sia pure drammatica, sia effettivamente quella che viene narrata.
Il rischio di alimentare complotti
Patenti, autorizzazioni e divieti darebbero solo nuova linfa a dietrologi, complottisti e sostenitori delle teorie più balzane.Benché, dunque, la soluzione sembri un po' sgangherata, alcuni problemi sono reali. Non v'è dubbio che una corretta informazione contribuisca a creare comportamenti virtuosi, i quali aiutano a contenere il contagio. E non v'è dubbio che non sempre gli scienziati abbiano fornito risposte univoche alle domande della pubblica opinione, anche alle più banali.
Di qui il diffuso disorientamento di chi attende ingenuamente dalla scienza verità inequivoche e trova nei media ipotesi, dubbi e spesso anche opinioni radicalmente diverse.
La risposta più efficace, tuttavia, non ci sembra quella ipotizzata nell'ordine del giorno. Quest'ultimo, a parte i problemi “di merito” e “di legittimità” già accennati, non farebbe altro che burocratizzare e ingessare il flusso del dibattito. Sulla base, peraltro, di una concezione verticistica che poco corrisponde alla ispirazione della nostra Costituzione in materia di libertà della scienza, diritto di parola e interesse della collettività a essere informata.
Come avanza la ricerca scientifica
Inoltre, varrebbe forse la pena ricordare che la ricerca scientifica avanza per continui tentativi di falsificazione delle certezze raggiunte. Che tali possono ancora essere definite poiché – e finché – esiste la continua critica dell'intera comunità scientifica, tesa al superamento di quanto ritenuto accertato. È “vero” ciò che ha resistito a chiunque abbia tentato di metterlo in discussione.
E più sono le ipotesi che hanno fallito, più solida appare la “verità” raggiunta. Insomma, posso dire che credo alla legge di Newton poiché chi ha cercato di dimostrarne la erroneità non c'è riuscito.
Dunque, è non solo fisiologico ma anche salutare che i ricercatori, anche nel dibattito pubblico, tentino in continuazione di porre in dubbio e “rovesciare” quelle che sono ritenute le conquiste della scienza che loro stessi studiano e contribuiscono a creare. E a volte i progressi vengono compiuti proprio perché c'è stato chi ha pensato l'allora impensabile, che in seguito a un processo severo di verifica è diventato il sapere ufficiale del futuro.
Per comunicare serve un metodo
Esiste tuttavia un livello di conoscenze condiviso che, in un dato momento storico, costituisce il meglio che il metodo scientifico ha distillato in un determinato ambito. E questa dovrebbe forse essere l'informazione che il Governo dovrebbe garantire tramite canali ufficiali.
Poche semplici risposte alle domande più frequentemente poste dalla vita quotidiana, dotate della “validazione” della comunità scientifica e supportate da dati verificati. Avendo anche il coraggio di distinguere tra certezze, ipotesi e consigli.Il mondo dell'informazione, dal canto proprio, dovrebbe forse meglio adempiere al ruolo di traduttore del sapere specialistico dalla nicchia di esperti alla generalità dei cittadini. Anche in questo caso distinguendo e precisando quelli che sono spunti, intuizioni o teorie non ancora verificate o approdi mai finora incrinati dal dubbio. Certo, nel caso di una pandemia del tutto nuova questa distinzione sfuma.
Il ruolo degli ordini professionali
Tuttavia, qui un ruolo, più che dalla pubblica amministrazione, potrebbe essere giocato dagli ordini professionali, sia dei giornalisti sia dei medici. Dare la parola solo a chi abbia il placet del potere può sembrare una facile scorciatoia, soprattutto in periodi di emergenza, per bonificare l'aria del dibattito.
Ma, in realtà, simili metodi non fanno che creare più problemi di quelli che risolvono, rischiando di condurre in un labirinto inestricabile. Ancora una volta è bene lasciare che il legislatore intervenga a sanzionare gli abusi della libertà di espressione ma si astenga prudenzialmente dal prevenirli, dotato com'è in questo ambito di guanti di legno.
Per visualizzare questo contenutoapri la pagina su ilsole24ore.com
Giulio Enea Vigevani
collaboratore
Carlo Melzi d’Eril
collaboratore